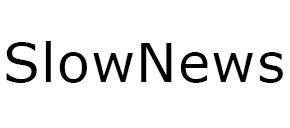Siamo abituati a sentir ripetere che la democrazia consiste nel potere della maggioranza di fare e disfare il mondo a suo piacimento. Guai a intralciarla. L’essenza della democrazia, al contrario, sta proprio negli intralci (la divisione dei poteri).
Sono questi limiti a consentire a ciascuna persona, benché in minoranza – tutti noi siamo minoranza in qualche segmento dell’esperienza umana – di sentire comunque la democrazia come la propria casa.
La democrazia si regge su una contraddizione vitale: il potere della decisione politica, da un lato, il pluralismo irriducibile delle esperienze personali, dall’altro.
Nell’aula giudiziaria ogni persona si aspetta che il magistrato sappia distinguere, sceverare, interrogare i fatti e interpretare le norme per adeguarle al teatro dell’esperienza umana.
Sappia, anche, dissentire dalla legge difforme dalla Costituzione e aprire le porte della Corte costituzionale o delle Corti sovranazionali: basti pensare alla preziosa disciplina del ‘fine vita’ per rendersi conto di quanto quel dissenso sia prezioso nelle vicende di donne e uomini.
Perché ciò accada, servono magistrati non intimoriti, forti della possibilità – una forza sempre bilanciata dal sapere – di presidiare la propria sfera di autonomia e l’indipendenza dell’azione giudiziaria.
Tutto il contrario di quello che emerge dalla riforma, che con la scusa della separazione delle carriere, pretende di ingabbiare l’autonomia di pubblici ministeri e anche dei giudici, costruendo una giurisdizione plasmata dai rami alti della politica.
La separazione della carriere costituisce soltanto il grimaldello, il cavallo di Troia di un programma di ridefinizione dei rapporti tra politica e potere giudiziario a tutto vantaggio della prima; in sostanza, di riduzione dell’indipendenza esterna e interna di tutta la magistratura, giudici compresi.
Al posto di un solo Consiglio Superiore della Magistratura, ne avremo due: uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri.
Lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura non è necessario a recidere il rapporto di colleganza tra giudici e pubblici ministeri.
L’operazione divisoria, presenta sotto l’abbaglio di un raddoppio, la realtà del dimezzamento. Il vero problema, infatti, è che i consigli immaginati nella riforma non saranno per nulla identici al loro progenitore.
I membri di nomina politica verranno estratti a sorte da un elenco che il Parlamento, in seduta comune, “compila mediante elezione”; i membri provenienti dalla magistratura saranno estratti a sorte dall’intera platea dei magistrati giudicanti.
È una formula elegante per dire che la politica continuerà a scegliere i propri rappresentanti – si sorteggia tra un ventaglio di eletti –, mentre giudici e pubblici ministeri affideranno al puro caso. Insomma, la fortuna sarà cieca sul versante della magistratura, mentre vedrà benissimo nel campo della politica.
Le conseguenze dell’asimmetria sono evidenti: si passa dal governo autonomo della magistratura a una elevatissima probabilità di governo politico.
La componente laica sarà in grado esercitare egemonia attorno al proprio punto di vista e potrà pilotare l’azione consiliare in ogni campo: dalla nomina dei capi degli uffici – era quello che si provava a realizzare nello scandalo dell’hotel Champagne.
Secondo risultato effettivo: solo per i magistrati ordinari – non per quelli amministrativi, non per quelli contabili – verrà istituita un’Alta Corte con il compito di esercitare la giurisdizione disciplinare.
Anche in questo caso, la composizione è tutta sbilanciata a favore della politica: su quindici giudici, tre verranno scelti dal Presidente dalla Repubblica e tre estratti a sorte dal famoso elenco compilato mediante elezione dal Parlamento.
Gli altri nove componenti verranno sorteggiati tra i magistrati, ma, si badi bene, solo tra quelli che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità. Tradotto in linguaggio più accessibile, solo tra quelli che siedono presso la Corte di Cassazione, i magistrati alti.
In un colpo solo, l’Alta Corte pone in pericolo l’indipendenza esterna e interna: la leva disciplinare potrebbe essere utilizzata per punire il magistrato scomodo alla politica e critico nei confronti degli orientamenti della Corte di Cassazione.
I tratti della riforma appena esaminati dimostrano che la separazione delle carriere è un pretesto per mettere mano ad “altro”:
l’ingabbiamento dell’indipendenza della magistratura, dal tentativo di creare un magistrato burocrate, di nuovo inserito in una gerarchia, intimorito dalla politica e dai superiori.
Questo “altro” è un arsenico che avvelena per chiunque il piatto della separazione della carriere e che mette a rischio la democrazia. (Riccardo De Vito, giudice al Tribunale di Nuoro)